Padova: la maratona Prokof’ev è una sfida vittoriosa
Nel 1913, la vita musicale europea si nutriva di “scandali” da un capo all’altro del continente. Alcuni sono ben noti: a fine marzo l’esecuzione a Vienna di musiche di Schoenberg, Berg e Webern causò tumulti tali da richiedere l’intervento della forza pubblica; a fine maggio a Parigi il debutto del Sacre du printemps di Stravinskij conobbe clamorose contestazioni. Meno conosciuto è l’evento che segnò la nascita del caso-Prokof’ev, la prima esecuzione del suo secondo Concerto per pianoforte e orchestra, avvenuta il 3 settembre di quell’anno a Pavlovsk, poco lontano da San Pietroburgo. Alla tastiera c’era il compositore ventiduenne – già salito alla ribalta non certo come tradizionalista l’anno precedente con il suo primo Concerto – e l’articolo sulla serata comparso sulla Gazzetta che si pubblicava nella capitale russa lo descriveva così: «Egli prende posto al pianoforte e pare che si metta a spolverare i tasti o a percuotere a casaccio note acute o gravi. Ha un tocco tagliente, secco. Il pubblico è sconcertato…». Segue il racconto di proteste di vario genere, di persone che abbandonano la sala ostentatamente, di fischi contro i quali si levano le voci dei non numerosi entusiasti, convinti che il Concerto sia geniale. Prokof’ev si diverte a fare il provocatore: il suo inchino finale viene definito “beffardo” e la concessione di un bis, fra le contestazioni, è chiaramente provocatoria.
Il compositore russo sarebbe tornato al Concerto pianistico nel 1921, otto anni, una guerra e una rivoluzione più tardi, durante un lungo soggiorno negli Stati Uniti. Il suo modernismo questa volta non turbò nessuno, anche se il clima espressivo e il linguaggio non sono poi molto distanti da quelli del lavoro precedente. Domina una fantasia spinta al calor bianco sul piano dell’inesauribile vivacità ritmica, della brillantezza e dell’ampiezza dei colori in orchestra, naturalmente e specialmente di un linguaggio pianistico che passa dalla congestione virtuosistica quasi parossistica alla distensione lirica trasognata. L’accidentato percorso di Prokof’ev verso lo stile neoclassico si dimostra pieno di deviazioni di formidabile forza soggettiva, a partire specialmente dal trattamento della forma, straordinariamente libera all’interno di movimenti dai nomi tradizionali.
Il secondo e il terzo Concerto rimangono oggi i più noti ed eseguiti, banco di prova d’obbligo per generazioni di virtuosi. Gli altri tre composti da Prokof’ev, però, non sono meno interessanti, nonostante siano sostanzialmente ai margini del repertorio. A maggior ragione, l’esecuzione integrale di queste cinque composizioni (la quarta e la quinta risalgono ai primi Anni Trenta, alla vigilia del definitivo rientro in Russia) è un’occasione d’ascolto speciale quanto rara. Si tratta di una vera e propria maratona musicale, e per una volta il termine non ha un significato soltanto metaforico: l’esecuzione dura infatti, più o meno, lo stesso tempo impiegato dai migliori fondisti nella gara sui 42 chilometri e 195 metri, due ore e una manciata di minuti.
Il progetto – del quale non sembra esistano precedenti, almeno in Italia – è stato ideato da Marco Angius, direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto, e dal pianista quarantunenne Alessandro Taverna, veneto di Portogruaro, che della compagine patavina è il solista “in residence”. L’evento si è tenuto, con trionfali accoglienze, giovedì al teatro Verdi di Padova, nell’ambito della stagione “Integrali e derivate”. Non c’era il pubblico delle grandi occasioni (molto i vuoti in platea), ma ha ragione Angius quando rivendica l’originalità e il valore di una scelta che «contrasta con il consumo dei nostri tempi, che predilige la clip, l’usa e getta dell’ascolto». Non fermarsi pur sapendo che il pubblico avrebbe risposto in maniera tiepida (e chissà, forse timorosa…) ha avuto anche il senso di una rivendicazione dei valori della cultura e della storia. E questo proponeva l’ascolto di tutti cinque i Concerti per pianoforte di Prokof’ev nella stessa serata: l’occasione per gettare uno sguardo sulla storia della musica e sul pianoforte del XX secolo nella prospettiva di uno degli autori più significativi ma forse oggi – tranne poche pagine consegnate alla popolarità – meno conosciuti.
Si è potuto cogliere, ad esempio, come questi Concerti realizzino un singolare “arco” stilistico che nel giro di un ventennio prende le mosse dall’innovazione spesso febbrile del gesto creativo giovanile per arrivare a una rivisitazione dello stile neoclassico nel segno di un’autonomia (rispetto alla linea stravinskiana) che fa tesoro di suggestioni espressive sedimentate sia nella tradizione russa che in quella occidentale. E mentre il n. 5 condensa la scrittura pianistica in un virtuosismo che si muove fra i poli della esasperazione “meccanica” digitale e della perorazione poetica introspettiva, quasi rarefatta, il n. 4 scritto per la mano sinistra, “approfitta” della limitazione imposta dal committente (lo stesso pianista, Paul Wittgenstein, che avendo perso il braccio destro in guerra aveva chiesto a Ravel il ben noto Concerto) per delineare un lirismo lontano da esasperazioni virtuosistiche, essenziale nelle linee del discorso pianistico, decisivo nell’affermare la cifra scura e un po’ misteriosa di quello che uno specialista come Piero Rattalino considerava uno dei capolavori assoluti nell’intera storia del Concerto per pianoforte e orchestra.
La sfida di un’esecuzione di queste cinque partiture nella stessa serata è una questione tecnica e di pensiero, di tenuta fisica (stavamo per scrivere “atletica”…) non meno che psicologica. Si tratta di attraversare una gamma molto articolata di suggestioni espressive coagulate in una scrittura fremente e poetica, mai uguale a sé stessa. E di dare l’idea, comunque, di come e quanto il pensiero di Prokof’ev si sia evoluto, sia cambiato nei vent’anni durante i quali si dedicò a questo genere. Fra l’altro, il programma opportunamente non era articolato in ordine cronologico (che per qualche aspetto avrebbe facilitato il compito di tutti gli esecutori), ma in due blocchi a loro modo “autonomi”, per quanto evidentemente coordinati. Il primo si apriva con il n. 1 per poi passare al capo opposto della “grande avventura” con il n. 5 e concludersi con il n. 3. Il secondo si è aperto con il n. 4 – in atmosfera diametralmente opposta a quella al calor bianco raggiunta prima dell’intervallo, prima di affidare la chiusura al n. 2 – in certo modo il manifesto di Prokof’ev come virtuoso.
La sfida è stata vinta da Alessandro Taverna con straordinaria uniformità di energia interpretativa, senza cali alla distanza, senza momenti di pausa: acceso il fuoco dell’invenzione di Prokof’ev, il suo calore non è mai venuto meno, grazie a un pianismo di sontuosa forza tecnica e di sorvegliatissima qualità nel suono. Dentro alle furenti ottave martellate da un capo all’altro della tastiera, come pure nel disegnare atmosfere notturne o sognanti (le percussioni e le “spolverate” di cui parlava la Gazzetta di Pietroburgo nel 1913), il suo tocco è sempre apparso al servizio di un pensiero interpretativo di convincente immediatezza: in questi capolavori la musica russa conosce uno dei suoi momenti più alti all’insegna di una multiformità espressiva sbalorditiva, e di essa Taverna ha reso la complessa profondità in maniera rivelatoria. Come pure ha dato ragione, con evidenza esemplare, della insopprimibile e affascinante tendenza metamorfica di una scrittura letteralmente “mutante”.
L’Orchestra di Padova e del Veneto è stata co-protagonista dell’impresa con evidente adesione alla straordinarietà del progetto. Marco Angius ha dipanato la trama strumentale delle cinque partiture con eloquenza incisiva e accattivante, esaltando in efficacia coloristica la densità spesso disegnata da Prokof’ev per gli archi, la brillantezza mai banale del discorso tra i fiati, la valenza quasi strutturale rivestita all’ampia compagine delle percussioni, nulla di più lontano dalla ricerca dell’effetto esteriore. Esemplare l’equilibrio fra orchestra e tastiera, in un contesto di mobilità sia dinamica che agogica tale da postulare anche qui un virtuosismo non di maniera, individuato e realizzato come meglio non si poteva.
Probabilmente nessuno fra il pubblico pensava che alla fine di questo straordinario e faticoso viaggio musicale Alessandro Taverna si sarebbe concesso alla tradizione del bis. E invece il pianista non si è sottratto – quasi per dare l’idea che per quanto lo riguardava, la sua notte sulla tastiera era ancora giovane. Così, l’ultima parola dopo tanto Prokof’ev è toccata al sommo pianista Friedrich Gulda, che non solo era anche un compositore ma aveva una proclamata passione per il jazz, evidente nelle rapidissime per quanto un po’ manierate “volate” bluesy della sua Toccata. Quasi inutile dirlo: esecuzione di precisione acuminata e travolgente.
Cesare Galla
(10 aprile 2025)
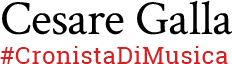
La locandina
| Direttore | Marco Angius |
| Pianoforte | Alessandro Taverna |
| Orchestra di Padova e del Veneto | |
| Programma: | |
| Sergej Prokofiev | |
| Tutto in una sera | |
| Integrale dei concerti per pianoforte e orchestra | |





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!