Vicenza: Lonquich e il Novecento al microscopio
Dieci anni, scarsi, della storia musicale del Novecento, nell’epoca che porta alla Seconda Guerra mondiale e nei primissimi anni del conflitto. Era questa la ristretta “finestra” cronologica – suddivisa fra quattro compositori – disegnata dal programma sicuramente originale, e per molti aspetti inconsueto, del terzo concerto della stagione dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. La formazione strumentale giovanile si è presentata in formazione di soli archi, e il pianoforte (alla tastiera oltre che sul podio il direttore musicale Alexander Lonquich) ha avuto un ruolo più del solito importante. Questo nonostante in locandina ci fosse soltanto un Concerto per pianoforte e orchestra, quello in Do minore op. 35 di Šostakovič, che peraltro concede abbastanza poco alla gloriosa tradizione di questo genere, visto lo spazio che il musicista russo concede anche a una impertinente (e a tratti raffinata) tromba, in dialogo talvolta serrato con la tastiera.
Questo Concerto – posto a concludere la serata – era anche il brano più “antico” della serata: risale al 1933, negli anni seguenti al debutto dell’opera ll naso, accolta da grande successo ma anche da molte discussioni. Di lì a poco, sull’onda delle contestazioni politiche alla sua seconda opera, la cupa e feroce Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, Šostakovič sarebbe entrato nel periodo più difficile della sua vita, passato con il terrore dell’epurazione da parte del regime stalinista. In questa pagina concertante, tuttavia, domina ancora il taglio brillante e irridente caratteristico dell’opera da Gogol.
Agli anni terribili fra il 1939 e il 1941 risalivano invece gli altri tre brani in programma, in due dei quali è presente anche il pianoforte, e sia pure in una posizione non solistica in senso tradizionale. In apertura c’era la Fanfara Young Apollo per pianoforte, quartetto e orchestra d’archi scritta da Benjamin Britten in Canada, durante una tournée concertistica. Una pagina giovanile bizzarra, quasi congestionata dal punto di vista sonoro, irruente ma anche singolarmente inconsistente dal punto di vista formale, se si pensa alla raffinatezza e profondità future di questo musicista capitale nel Novecento. E si può capire che l’autore abbia ritirato questo suo lavoro dopo le prime due esecuzioni, senza mai pubblicarlo finché è vissuto.
Ben altro peso strutturale aveva il successivo Die vier temperamente, “Tema con variazioni per pianoforte e orchestra d’archi” con il quale Paul Hindemith nel 1940 – appena giunto negli Stati Uniti al riparo dal regime nazista che lo aveva dichiarato autori di “musica degenerata” – ripensa al gusto barocco per la musica dedicata ai “caratteri” dell’uomo, qui sintetizzati nel malinconico, il sanguigno, il flemmatico e il collerico. Secondo opportuna alternanza di suggestioni espressive e conseguenti scelte di tempo e di andamento. Lo stile si potrebbe definire una sorta di neoclassicismo alla tedesca, denso e pensoso, complesso negli intarsi polifonici della scrittura, poco accattivante nella definizione timbrica.
Al confronto, trasparente nella sua essenzialità “alla francese” è sembrata la seconda Sinfonia per orchestra d’archi di Arthur Honegger (1941). In questa composizione compare, all’ultimo dei tre movimenti, anche un breve intervento di una tromba, unica apertura di speranza – su un tema di Corale – in un discorso musicale di cupezza congrua con gli avvenimenti tragici dell’epoca in cui la composizione prese forma, ma comunque di raffinato equilibrio nella sottigliezza della gamma espressiva. Il momento più alto è l’Adagio mesto che sta al centro, una pagina fra preghiera e lamentazione cui assicura un tocco di sofisticata poesia il ruolo quasi concertante del primo violoncello.
Gli archi della OTO hanno fornito, alle prese con questa pagina, prova dell’eccellente lavoro di preparazione che i tutor Filippo Lama e Pierantonio Cazzulani (violini), Klaus Manfrini (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello) e Ubaldo Fioravanti (contrabbasso) realizzano insieme ai giovani strumentisti partecipanti al progetto. Lo si è sentito nella corposa ricchezza del suono, nella sua omogeneità mai disgiunta dalla duttilità e dalla precisione del fraseggio, nella pertinenza della definizione stilistica, rifinita da Lonquich con gesto netto e visione lucida e approfondita. La stessa che aveva illuminato le tortuose elucubrazioni di Hindemith. Quanto al Concerto di Šostakovič, il pianista di Treviri ne ha fornito un’interpretazione brillantissima alla tastiera, con suono tagliente ma sempre magnificamente controllato nelle sue ironiche intemperanze percussive, curando al tempo stesso una lettura orchestrale precisa e coinvolgente, fra l’ironia nei movimenti estremi, densi di citazioni classiche, e la meditabonda profondità secondo movimento, nel quale si è fatto valere per sfumature coloristiche (con sordina) il trombettista Francesco Manco, impeccabile peraltro anche nelle stentoree perorazioni del Finale.
Pubblico discretamente numeroso al teatro Comunale Città di Vicenza e prodigo di applausi cordiali: come bis è stato riproposto per intero il Lento del Concerto dell’autore russo.
Cesare Galla
(3 febbraio 2025)
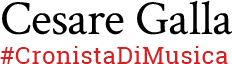
La locandina
| Direttore e pianoforte | Alexander Lonquich |
| Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza | |
| Programma: | |
| Benjamin Britten | |
| Young Apollo Op. 16 | |
| Paul Hindemith | |
| Tema con quattro variazioni (Die vier Temperamente) per pianoforte e orchestra d’archi | |
| Arthur Honegger | |
| Sinfonia n. 2 per archi e tromba in Re maggiore | |
| Dmitri Shostakovich | |
| Concerto per pianoforte, tromba con accompagnamento di orchestra d’archi n. 1 in Do minore Op. 35 | |






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!